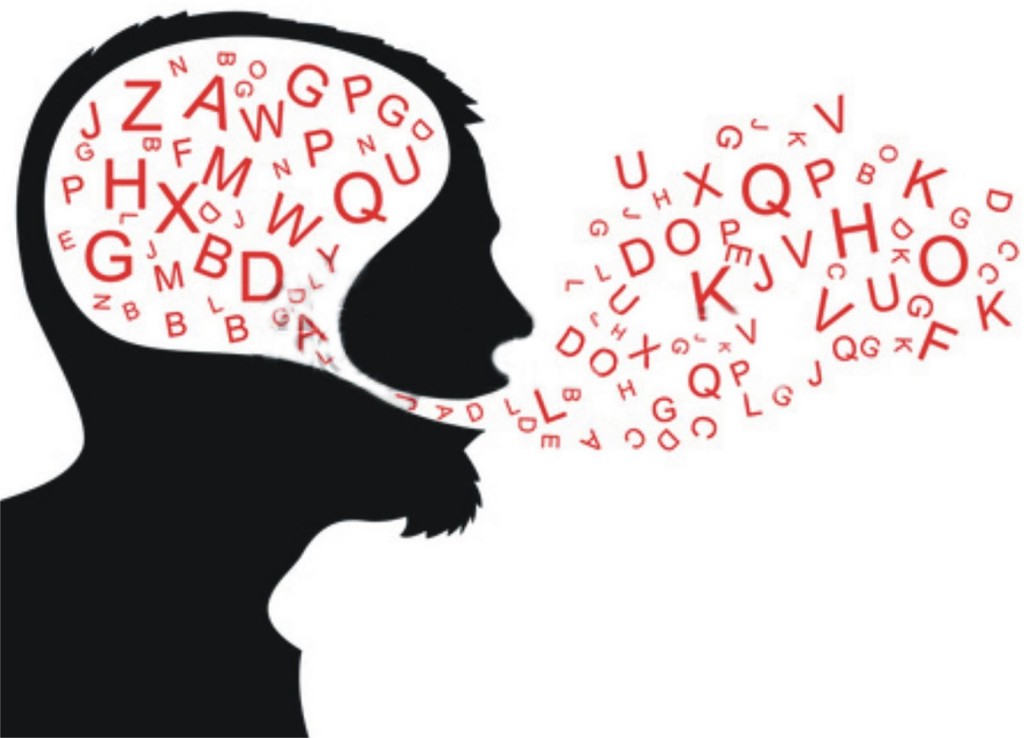L’intervista di Carta di Roma a Tullio De Mauro nella giornata contro il razzismo
Di Anna Meli
Francesco Bonami dalle colonne de La Stampa affermava che «il grande paradosso italiano è che pur vivendo in una dittatura del talk show, travolti quotidianamente da tsunami di parole, loro, le parole, da noi non hanno nessun valore sociale e nessuna conseguenza morale». Per una categoria professionale come quella dei giornalisti, che del linguaggio e delle parole ne fa uso e strumento quotidiano, il tema è centrale e particolarmente sensibile. C’è sempre il dubbio e che raccomandazioni e regole lessicali possano allontanare dalla sostanza dei fatti in nome di principi “politicamente corretti”. Abbiamo quindi chiesto al professor Tullio De Mauro, linguista docente di filosofia del linguaggio presso l’Università di Roma, un parere sul valore sociale delle parole e, da ex ministro della Pubblica Istruzione ed esperto del mondo della scuola, un commento sui recenti dati del Miur (ministero dell’Istruzione) sulla presenza degli alunni stranieri nelle scuole italiane.
Qual è a suo avviso l’importanza e il peso che ha il linguaggio utilizzato dai media nella rappresentazione dei migranti?
«Le parole non sono simboli di un’algebra astratta. Non ci servono solo a indicare cose e azioni, ma anche segnalano, magari senza che ce ne rendiamo conto, chi siamo che le adoperiamo e come ci collochiamo verso ciò di cui parliamo. Questo vale sempre, vale tanto più quando la parola, scritta o trasmessa, è destinata a un vasto pubblico. L’attenzione alla chiarezza e precisione dovrebbe combinarsi con altrettanta attenzione a limitare ciò che può ferire e offendere. Quello che trasmettiamo a un vasto pubblico andrebbe sempre letto, mentre scriviamo, con gli occhi dei destinatari, specialmente con gli occhi delle persone di cui parliamo».
Quando parliamo di correttezza del linguaggio dei media si viene spesso accusati di essere politically correct senza badare alla sostanza dei fatti riportati. È un rischio reale a suo avviso un eccesso di “politicamente corretto”?
«Meglio qualche pesantezza e rigidità che usi discriminatori delle parole. Meglio “bambini e bambine”, “donne e uomini” piuttosto che “bambini” e “uomini” cassando l’altra metà del cielo».
In un suo pezzo per la rubrica che cura su Internazionale ha parlato del mondo del giornalismo però anche come una risorsa pedagogica, facendo riferimento alla Francia e alla raccomandazione fatta agli insegnanti di consultare il sito franco-tedesco di Arte che, dopo il dramma di Lampedusa, ha messo in rete un dossier completo per capire i meccanismi dell’immigrazione irregolare in Europa. Vede questa possibilità anche in Italia? Il mondo della scuola e il mondo dell’informazione come potrebbero o dovrebbero dialogare su questo tema?
«Chiediamo da tanti anni che questo dialogo ci sia. È prezioso per chi insegna e studia e quando avviene, prezioso anche per chi fa informazione. Nel dialogo chi informa può rendersi conto di approssimazioni e mediocri usi linguistici, ma anche di lacune gravi dell’informazione fatta spesso dando per scontato quel che per i destinatari scontato non è».
La presenza dei ragazzi stranieri nella scuola viene spesso raccontato come un ostacolo ai percorsi di studio nelle classi. Cosa ne pensa e come interpreta lei i dati del Miur che vedono effettivamente una difficoltà negli alunni figli di immigrati soprattutto nel passaggio alle scuole superiori, con alti tassi di abbandono.
«Il discorso non è breve. Se chi insegna centra il suo lavoro sulla comprensione di come si svolge l’apprendimento, come cresce o non cresce la comprensione, classi eterogenee sono un fattore di stimolo. E questo avviene,per fortuna, nelle scuole elementari, che nonostante ogni difficoltà continuano a figurare tra le migliori del mondo per i risultati cui portano bambine e bambini. I guai, non solo per chi è di origine o cittadinanza straniera, cominciano dopo, quando chi insegna pensa più al programma o alla materia e meno a chi deve capire e studiare. Ma, ripeto, non ne soffre solo chi è definito straniero».
Lei ha affermato che lo studio della lingua è solo un pezzettino, seppure importante, per comprendere quale sia lo stato culturale complessivo di un Paese. Il multilinguismo di cui sono portatori naturali i migranti e alcuni figli di immigrati se e come può essere un’opportunità per il nostro paese?
«Possiamo imparare da loro come nel nostro cervello possono coesistere bene più lingue e dalla lezione potremo forse trarre una spinta a uscire dal grave stato di ignoranza di lingue straniere in cui ci troviamo – insieme ai britannici, che hanno l’ovvio vantaggio di essere sì ignoranti come noi, ma parlando inglese».
Ritiene che la presenza degli immigrati influirà sullo sviluppo della lingua italiana, e in che misura? Vede già segnali di questo processo?
«Per ora non se ne vedono segni. Teniamo conto del fatto che, rispetto ad altri paesi, l’immigrazione italiana è polverizzata in nazionalità e lingue diverse. I paesi fonte di immigrazione sono quasi duecento. In pratica si viene in Italia da ogni paese del mondo. Non così altrove in Europa. Per l’immigrazione in Italia non ci sono le condizioni di una concentrazione su e di un’unica o quasi unica lingua, come è avvenuto in Francia per l’arabo, in Germania per il turco ecc. In più, tranne per chi viene dalla Cina, le possibilità e spinte a guadagnare rapidamente una discreta conoscenza dell’italiano appaiono molto forti, per quel che sappiamo. Di più ci dirà nei prossimi mesi la pubblicazione dei dati di una grande indagine dell’Istat ormai conclusa».
Anna Meli
Il Professor Tullio De Mauro è un linguista, docente di filosofia del linguaggio presso l’Università di Roma ed ex ministro della Pubblica Istruzione. Ha collaborato e collabora con numerosi giornali e settimanali. Dal 2006 cura una rubrica sul settimanale Internazionale e il suo libro più recente è «La cultura degli italiani» (Laterza 2010).