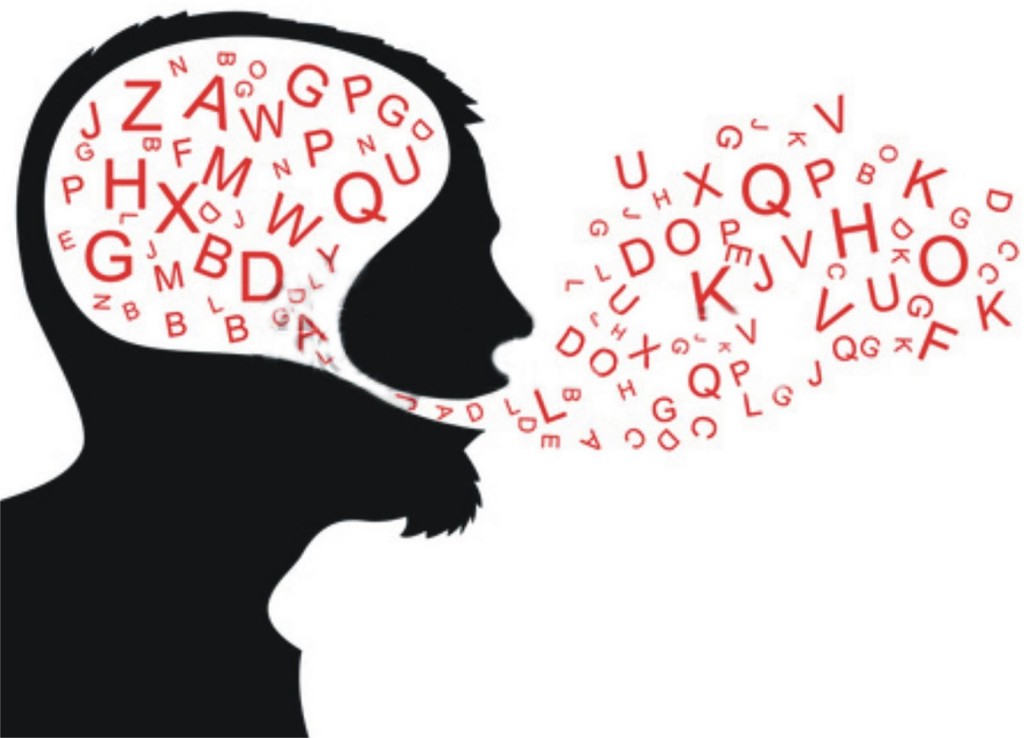“Mi tratti come una sguattera del Guatemala”, diceva la Guidi al compagno. La riflessione di Giuseppe Faso su quel linguaggio che riflette un immaginario ricco di discriminazioni e stereotipi
Di Giuseppe Faso
Pubblicato su Cronache di ordinario razzismo
In una delle tante intercettazioni date in pasto alla stampa, si può ascoltare una ex-ministra italiana che dice, assai preoccupata, al compagno: «Mi tratti come una sguattera del Guatemala». I casi sono due:
1. Federica Guidi e Gianluca Gemelli hanno assistito, in Guatemala o altrove, al trattamento disumano di una signora “addetta ai lavori più umili e pesanti di cucina” e proveniente dal Guatemala:
2. va ricercata nell’immaginario dell’una e dell’altro la presupposizione che permette alla Guidi di recriminare per un’umiliazione oltraggiosa; per la quale scatta senz’altro la nostra solidarietà umana con la signora Guidi, soprattutto adesso che non è più ministra e la possiamo ascoltare sine ira, studio et preoccupazioni per il posto che ricopriva.
Se dovessi scommettere, propenderei senz’altro per la seconda ipotesi. Non lo dico perché io a mia volta conosca i due conviventi in causa, ma per una serie di considerazioni.
Di origine longobarda, il termine “sguattera” ha in più rispetto all’originario “wathari” una bella s intensiva, che lo espone ad un uso più connotativo che denotativo. Non serve, cioè, prevalentemente a indicare un “addetto ai lavori più umili e pesanti di cucina”, ma comporta l’evocazione di risonanze affettive, positive o negative; in questo caso, negative.
È possibile che l’origine “Guatemala” piuttosto che “Equador” oppure “Perù” (stati da cui sono venute a lavorare nelle nostre case molte, ma molte più donne che dal Guatemala) sia qui usato per una analoga disponibilità connotativa: una connotazione sopra a un’altra, come l’aggiunta di un carico a un piatto già ricco in una mano di briscola in 5. Per non dire delle ragioni più “poetiche” della locuzione, la ripresa del suono “gua”: sGUAttera del GUAtemala. In questi casi, i suoni si rendono parzialmente autonomi rispetto ai significati. La Guidi dovrebbe scrivere in versi.
Quest’uso evocativo-connotativo mi richiama alla mente altre locuzioni simili, che sempre più sentiamo pronunciare o leggiamo scritte, anche da parte di persone che alcuni di noi si ostinano a ritenere più responsabili linguisticamente perché “addette ai lavori”.
Pochi anni fa, in un romanzo di successo, “Che la festa cominci” (2009), il noto scrittore Ammanitiscriveva, a p. 118: «in quel momento era spiritoso e vivace come un profugo ugandese». Un lettore capace e severo, recensendo il libro di Ammaniti, e criticandone l’uso di metafore implausibili, ha spiritosamente confessato: “non conosco nessun profugo ugandese”.
Paolo Nori ha ragione: in Italia c’erano allora non molti profughi da decine di paesi africani, ma era (e rimane) assai difficile che qualcuno conoscesse profughi provenienti dall’Uganda, e quindi capisse la metafora di Ammaniti grazie alla sola denotazione.
Ma se si presuppone una intenzione connotativa, le cose cambiano. È vero infatti che, per la fonetica esotica, “Uganda”, come anche “baluba”, “Mau mau”, “Zulu” richiama battute discriminatorie e razziste, assai diffuse in epoca fascista ma ancora attive.
Ha usato spesso in TV con disprezzo “baluba” un noto direttore di giornali, e non mi risulta che qualche conduttore ci abbia trovato da ridire, forse per rispetto a quelle tradizioni, che gli saranno parse rispettabili. Un efficace richiamo ironico a quest’uso di “Uganda” si trova in un famoso pezzo di Giorgio Gaber parlato, “Qualcuno era comunista”.
Anche nel caso di Ammaniti può aver giocato un’intenzione evocativa, la ripetizione del suono “ug”; profUGo dell’UGanda. Anche Ammaniti si dovrebbe dare alla poesia, soprattutto al non-sense per bambini, invece di raccontare storie.
Se “le metafore sono basate sull’esperienza” (Lakoff & Johnson), chiamare in causa un profugo dell’Uganda o una sguattera proveniente dal Guatemala non significa richiamare a un’esperienza conoscitiva (pressoché impossibile), e si presta piuttosto a evocare l’esperienza di un immaginario sprezzante, influenzato dal repertorio colonialista, e talvolta fissato in catene di suoni di facile memoria.
Preoccupa riflettere su che linguaggi frequenti, accetti e riproduca chi parla così. Non sarà forse la mancanza più incresciosa della signora Guidi e del suo compagno imprenditore. Ma di questo ci si occupa qui: della costruzione di un immaginario pullulante di discriminazioni e disumanizzazioni.